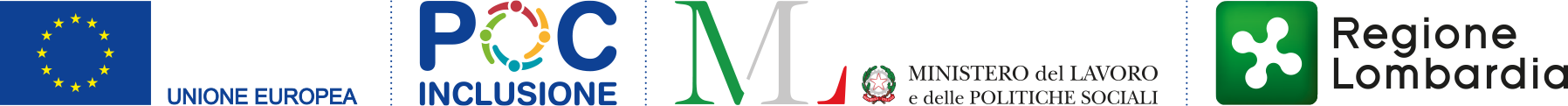Si richiameranno in modo molto sintetico i principali approcci oggi usati per misurare il lavoro som..
 Come ormai molti sanno, uno fra i partner del progetto InLav Lombardia è l’Università di Milano-Bicocca. La presenza nella compagine, insieme ad Anci Lombardia e Regione Lombardia, che ha dato vita al progetto dell’Università è un unicum nel panorama nazionale dei progetti di contrasto lo sfruttamento lavorativo, come ci conferma Egidio Riva, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, nonché Assessore al Welfare del Comune di Monza. Un duplice ruolo che rende ancor più significativa la partecipazione dell’Ateneo milanese.
Come ormai molti sanno, uno fra i partner del progetto InLav Lombardia è l’Università di Milano-Bicocca. La presenza nella compagine, insieme ad Anci Lombardia e Regione Lombardia, che ha dato vita al progetto dell’Università è un unicum nel panorama nazionale dei progetti di contrasto lo sfruttamento lavorativo, come ci conferma Egidio Riva, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, nonché Assessore al Welfare del Comune di Monza. Un duplice ruolo che rende ancor più significativa la partecipazione dell’Ateneo milanese.
Perché è importante la presenza di una Università in un progetto come InLav? E qual è stato ed è il suo ruolo? Lo abbiamo chiesto al diretto interessato.
Studiare e analizzare il fenomeno
“Avevamo pensato inizialmente il progetto con Anci Lombardia in modo tale da valorizzare questo unicum rappresentato dalla presenza dell’università in tre fasi. La prima è quella legata allo studio e all’analisi del tema. Siamo partiti da una constatazione, che le banche dati disponibili sia di fonte statistica che di fonte amministrativa non consentono di avere una stima del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e in particolare del lavoro irregolare. L’ipotesi progettuale che ci è sembrata più sensata era quella di un’integrazione tra le varie fonti dati disponibili sul mercato del lavoro e sui servizi sociali, per arrivare su base provinciale a offrire una rappresentazione di questo fenomeno. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo pensato che il sapere di alcuni colleghi universitari fosse quel quid in più più che consentisse un salto deciso importante. Non a caso a capo di questa prima fase c’è una collega economista che si occupa da tempo dello studio di questi fenomeni”.
Le fonti dati cui fa riferimento Riva sono molteplici, come per esempio i registri sulle imprese e le comunicazioni obbligatorie sulle forze di lavoro, senza escludere anche quelle degli istituti di ricerca che presentano ogni tanto una stima del lavoro irregolare in Italia.
“Le stime degli istituti di ricerca non sono puntuali. Il nostro obiettivo e stato, partendo dai dati di Regione Lombardia, avere una una misura più precisa, più puntuale di quello che stiamo cercando di fare. La presenza dell’Università garantisce competenze di natura tecnica che valorizzano queste fonti informative della Regione, non sempre sfruttate appieno secondo noi. Per questo abbiamo creato questa prima sinergia”.
Linee guida per la sperimentazione e la valutazione
Lo studio e l’analisi dei dati non ha esaurito l’intervento dell’Università, che si è esteso alla definizione della sperimentazione. Sul tema dello sfruttamento lavorativo, come conferma Riva, esiste un’ampia letteratura.
“L’Università si è posta come obiettivo quello di portare a sistema un insieme di conoscenze che riguardano il funzionamento dei centri per l’impiego, dei servizi per il mercato del lavoro da un lato e dei servizi sociali dall’altro. Questo lavoro ha offerto una cornice, un inquadramento utile ai vari ambiti per progettare la sperimentazione sul campo. L’Università ha fornito linee guida apprese dalla letteratura e costruito queste linee guida in modo che attraverso la sperimentazione sul campo venissero messe alla prova, venissero raccolte evidenze sul funzionamento di un modello o di un altro”.
La traduzione pratica di queste linee guida, che possono essere adattate dagli attori interessati, mira ad offrire suggerimenti per comprendere se la sperimentazione funziona bene, raggiunge i risultati sperati oppure viceversa non raggiunge gli obiettivi di progetto. Questo consente all’Università, ed è la terza fase, di svolgere le attività di monitoraggio e di valutazione. “Grazie all’applicazione pratica di queste linee possiamo raccogliere l’evidenza empirica che ci consente di capire quali siano le condizioni che permettono agli stranieri, in questo caso cittadini di Paesi terzi, di risolvere o superare o migliorare la loro condizione di potenziali vittime di sfruttamento”.
Problemi di definizione
Nelle prime giornate di formazione, Riva ha più volte sottolineato la questione della definizione di ‘sfruttamento lavorativo’. Una definizione è stata prevista di recente dalla legge, tuttavia, come sottolinea Riva, chi opera sul mercato del lavoro e nei servizi sociali non ha spesso un’idea chiara del termine. L’Università si è perciò impegnata tracciare un quadro dei termini giuridici, ovvero come la legge definisce il lavoro irregolare, il lavoro illegale, lo sfruttamento lavorativo.
“È un elemento di riflessione e nelle schede che abbiamo distribuito per monitorare la condizione dei beneficiari miriamo a raccogliere informazioni sulle varie dimensioni del lavoro, in modo particolare sulle varie dimensioni che possono permettere di interpretare le varie sfumature dello sfruttamento, per cui andiamo a declinare lo sfruttamento in termini di orari e condizioni di lavoro salario e di salute, igiene e via dicendo. Raccogliendo le schede, gli operatori acquisiscono una maggiore consapevolezza sulle dimensioni del fenomeno”.
Enti locali e Università
Un aspetto va comunque chiarito. Ci sono molti progetti che vedono impegnate le amministrazioni locali a fianco delle Università. In numerosi casi, tuttavia, si tratta di progetti per così dire tecnici, come nell’ambito del digitale o in quello urbanistico. Meno frequente la collaborazione su temi sociali e, probabilmente ancor meno su questioni legate al mondo del lavoro, come nel caso del progetto InLav, un progetto che tiene insieme ricerca e azione, come ci dice Riva.
“Con InLav stiamo costruendo un un sapere multidisciplinare su un tema particolare, a cui partecipano diversi soggetti. Come Università un elemento importante, come dicevo, è stato quello di portare a sistema una letteratura, nazionale e internazionale, consistente sul tema, che raccoglie esperienze, suggerimenti, che indica spiegazioni del fenomeno e le vie d’uscita auspicabili. Ci sono anni di ricerca nel nostro Paese e altrove e questi anni di ricerca hanno consolidato conoscenze che andrebbero opportunamente valorizzate nella costruzione degli interventi, delle misure. Nel nostro progetto il sapere dell’università passa anche attraverso una raccolta di dati che ci consentano di capire se anche quello che ha detto la letteratura trova conferma nel contesto locale”.
Un sapere multidisciplinare, che su questo tema coinvolge numerosi attori, perché la fragilità non si limita alle questioni lavorative, ma implica problematiche sociali, sanitarie, giuridiche. “Per questo” conclude Riva, “cerchiamo con il progetto di mettere in pratica un’integrazione amministrativa-operativa per quanto riguarda procedure e metodi tra servizi per il mercato del lavoro e servizi di natura sociale”.
Sergio Madonini
Ultime notizie
ANCI Lombardia, nell’ambito del pr..
Nella seduta del 20 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gl..